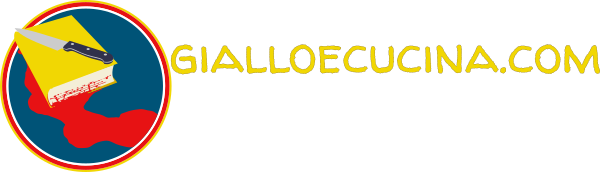La proposta per questo mese è: “Le quattro ragazze Wieselberger” di Fausta Cialente, vincitore del Premio Strega nel 1976. Il libro è un romanzo in cui l’autrice intreccia memorie personali e Storia, dipingendo il ritratto di un’epoca turbolenta attraverso le vicende di una famiglia triestina. L’idea di proporre questo libro mi è venuta leggendo un altro libro che ho recensito recentemente che tratta di irredentismo ed ha come protagonista una giovane ragazza trentina. Riflettendo su Trento e Trieste ho recuperato, come faccio spesso per questa rubrica, una vecchia lettura e la propongo per i temi trattati. Ambientato nella Trieste di fine Ottocento, che è ancora parte dell’Impero austro-ungarico, il romanzo segue le vite delle sorelle: Alice, Alba, Adele ed Elsa Wieselberger, cresciute in una famiglia dalla forte inclinazione culturale italiana. Questo legame con l’Italia si rafforza quando Elsa sposa un uomo di cognome Cialente e, nonostante il trasferimento, continua a tornare a Trieste con i figli Renato e Fausta (che è poi l’autrice del libro).
Il romanzo inizia nella Trieste asburgica, una città cosmopolita e multietnica, dove convivono italiani, slavi, tedeschi ed ebrei. Pur essendo sotto Vienna, Trieste ha una forte identità italiana nella borghesia (come la famiglia Wieselberger), il che crea tensioni con il governo centrale. È un porto fondamentale per l’impero, ricco di traffici commerciali e fermento culturale (vi nasce, ad esempio, la letteratura mitteleuropea di Svevo e Saba).
La Prima guerra mondiale (1914-1918) e la fine dell’Austria-Ungheria vede Trieste come un fronte caldo, gli italiani combattono contro l’Austria per annettere la città. Nel romanzo, questo periodo segna fratture familiari (es. simpatie diverse tra le sorelle) e lo sradicamento di chi aveva legami con Vienna. Con l’avvento del fascismo (1922) l’Italia diventa una dittatura. A Trieste, il fascismo è particolarmente aggressivo: repressione delle minoranze slave, chiusura di giornali antifascisti, violenze squadriste.
I temi storici ricorrenti nel romanzo riguardano l’identità nazionale, la condizione femminile nelle scelte, l‘esilio e la memoria. La Cialente usa la storia delle sorelle Wieselberger (sua madre e le sue zie) per raccontare il Novecento delle persone comuni, travolte da eventi più grandi di loro. Trieste, con le sue divisioni e contraddizioni, diventa un microcosmo dell’Europa in crisi.
Le vite delle protagoniste si intrecciano con gli eventi storici del Novecento: la Prima guerra mondiale, che segna la fine dell’Impero asburgico e l’annessione di Trieste e Trento all’Italia, e l’ascesa del fascismo, che divide ulteriormente le sorelle tra chi aderisce al regime e chi, invece, abbraccia l’antifascismo. Fausta Cialente, tratteggia con sensibilità i conflitti ideologici che lacerano non solo l’Europa, ma anche i legami familiari.
Il protagonismo femminile è centrale: le Wieselberger sono donne relativamente libere, ad Elsa la più giovane delle quattro sorelle, verrà concesso di andare a studiare canto a Bologna; la sorella maggiore, Alice, sposerà un giovane ebreo triestino, molto abile come commerciante. Sebbene romanzato, il libro contiene elementi autobiografici: Fausta Cialente, racconta del forte legame che legava lei e suo fratello a Trieste e alla casa dei nonni materni. Ogni anno le vacanze estive venivano passate nella casa di campagna della famiglia Wieselberger, dando una stabilità alla vita nomade della famiglia Cialente, dovuta al fatto che il padre di Fausta fosse un militare di carriera e i traslochi all’ordine del giorno.
Il legame con Trieste – città divisa tra identità italiana, slava e mitteleuropea – segneranno profondamente la sua scrittura. Nella parte finale del libro dove CIalente racconta del lungo periodo nel quale visse e lavorò in Egitto, la dimensione personale aggiunge profondità al racconto e favorisce la riflessione sulla memoria e sull’appartenenza.
Come detto sopra, il libro vinse il premio Strega nel 1976, anno in cui lo lessi, ora come allora penso che Cialente sia stata davvero brava a unire una storia familiare alla Storia. La scrittura è elegante e ottima la capacità di descrivere le emozioni.
Perché leggerlo? Per chi ama i romanzi familiari a sfondo storico, per chi vuole esplorare le contraddizioni o semplicemente per scoprire una delle voci più intense (e spesso sottovalutate) della letteratura italiana del ’900.
Trama
In una incantevole Trieste fine Ottocento, vivificata dall’aria mitteleuropea e dalla bora dell’irredentismo, si muovono, aggraziate, e come consapevoli di un loro tragico destino, le quattro sorelle Wieselberger. Appartengono a una della buona società: la madre è una tranquilla signora, che si divide tra la casa di città, odorosa di cera e di pulito, e la grande casa di campagna, con giardino, orto e vigna; il padre è uno stimato musicista, che dirige con autorità affettuosa sia la famiglia che l’orchestra dei “dilettanti filarmonici”. Narrando la loro storia, che è poi quella della sua ramificatissima famiglia, Fausta Cialente racconta mezzo secolo di storia. Integrando la memoria con la fantasia e cogliendo i nessi espliciti e sotterranei tra vita privata e pubblica, tra individuo e storia, «Le quattro ragazze Wieselberger», vincitore del Premio Strega nel 1976, porta a compiuta maturità umana ed espressiva l’attività di scrittrice svolta dalla Cialente nell’arco di quarant’anni e realizza il senso, più segreto e vero, della sua vocazione artistica.