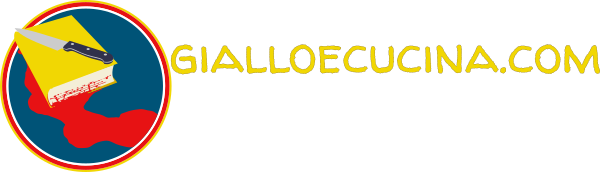Regia di Alessandro Piva
Film del 1999 con Dino Abbrescia, Paolo Sassanelli, Mimmo Mancini, Dante Marmone, Mino Barbarese, Tiziana Schiavarelli, Nicola Pignataro, Teodosio Barresi, Pinuccio Sinisi
Per quanto realistici o finanche ambientati in contesti in cui viviamo quotidianamente, è raro che i gangster-movie ci raccontino personaggi che sentiamo “antropologicamente” vicini. Certo, le loro avventure ci coinvolgono, ci colpiscono e ci divertono, persino: ma la stragrande maggioranza dei cultori del genere non commetterebbe mai i crimini di cui essi si macchiano, e quandanche ci capiti di incontrare al bar sotto casa o per strada personaggi che non hanno nulla da invidiare ai gangster dei film, per noi essi sono spesso un’umanità “altra”, incompatibile con la nostra.
In questo – e non solo -, La Capagira fa davvero eccezione. Quelli che popolano la pellicola sono al massimo “mezzi gangster”, ovvero appartengono alla piccola malavita, a quel sottobosco criminale che è, poi, la zona di confine tra gli “onesti” e i delinquenti veri. In dialetto barese “m’aggir’ la cap’” non si usa soltanto in senso letterale, ma anche per dire: bada bene, adesso mi sto incazzando. Ed è appunto a Bari – nelle sue campagne disseminate di rifiuti, nei suoi sobborghi degradati, negli anfratti di quella città vecchia dove, fino a pochi anni fa, era meglio non aggirarsi -, città-simbolo di un meridione che si è adattato alla meno peggio ai ritmi e ai canoni della modernità, che il film ha il suo teatro.
Qui, sui binari, si aggirano Pasquale e Minuicchio, due “fattoni” parte di una piccola banda capeggiata da un energumeno prepotente, volgare e violento, senza mezzi termini, che ostenta il suo “status” di piccolo boss sfoggiando ciondoli e anelli d’oro e trattando tutti come pezze da piedi – tranne il vigile che deve annullargli la multa perché ha parcheggiato in Piazza della Prefettura… -, dedita allo spaccio, al gioco d’azzardo illegale (videopoker), al trasporto degli immigrati clandestini. Cercano un fagotto di cocaina, che “Radio Tirana”, albanese “integrato”, che parla barese ma con l’accento slavo, ha lanciato fuori da un treno in corsa, perché, come dice Peppino, la “vedetta” del gruppo, “dakk’ssì iè cchiù s’kur’”. Ma il pacco non si trova, e Sabino, che gestisce il bar (con annessa sala giochi illegale nel retro) in cui i clienti si riforniscono di coca e sigarette di contrabbando, è “fermo” da giorni.
La ricerca della neve è il pretesto narratologico per raccontarci questi personaggi, e già da ciò che si è appena detto, molti di voi avranno sorriso affettuosamente, pensando all’amico o al parente che ha scelto di fare questa vita ma che, in fondo, è come noi: non ucciderebbe nessuno, non farebbe male a nessuno e anche quando si tratta di fare a botte, sono più le parole che i fatti; si limita a spaccarsi di spinelli, a sniffare ogni tanto, ad abbuffarsi in preda alla fame chimica e a procacciarsi qualche avventura sessuale.
È lo spaccato quasi documentaristico, per la spontaneità e l’intensità con cui il racconto arriva allo spettatore nonché per il suo realismo “verista”, delle periferie meridionali, non solo delle grandi città, ma anche dei piccoli centri, che sono interamente “periferie”, anche se hanno un centro storico e una via commerciale, in cui l’abulia esistenziale è la forma di povertà più pericolosa, che ogni giorno rinchiude le sue vittime nei bar frequentati da soli uomini, per lo più non molto presentabili quanto a igiene e maniere, dove nel retro, appartata, c’è la saletta delle “macchinette”, in cui pensioni e sussidi mensili si vaporizzano in poche ore; che spinge il suo esercito di disoccupati e di annichiliti, senza più nessuno stimolo e nessuna speranza di rivalsa, sulla via della dipendenza dall’alcool e dalle droghe nonché dello spaccio di stupefacenti; dove, insomma, vivere è soltanto arrivare a fine giornata.
Veicolo per eccellenza di tale neoverismo cinematografico sono i dialoghi in dialetto e il ricorso ai sottotitoli (molti anni prima che venisse fatto in Gomorra e simili): una scelta ardua ma efficace, che convinse molti dei critici del Festival Internazionale del Cinema di Berlino che Alessandro Piva avesse usato delinquenti veri nel film. Sulla stessa lunghezza d’onda, la madre di Dino Abbrescia – Minuicchio nel film -, che si sentì in dovere, da buona cristiana, di chiedere al figlio, preoccupata: “ma veramente vi siete fumati tutte quelle canne?”…
Eppure, proprio raccontando in maniera inedita e avvincente la periferia e la sua umanità, Piva è riuscito a liberarle da quella maniera cinematografica “coatta”, campanilista e demenziale che spesso le imprigiona, le cui pellicole sono da vedere solo per sganciarsi dalle risate e sfondarsi di canne (come successe davvero nei cinema di Bari allorché uscì): meraviglioso paradosso! A tal proposito, il sunto per eccellenza è il racconto divertito di Nicola Pignataro, uno degli attori del film, che in un’intervista ha descritto la faccia sconvolta di Leonardo Di Caprio quando, a Berlino, gli si pararono davanti alcuni degli attori del film; la star hollywoodiana sembrava davvero volesse urlare: “Ma chi ca… sono questi?!”.
C’è bisogno di aggiungere altro? Correte a vedere La Capagira: e poi cercate di inquadrarlo in un genere, se ci riuscite…