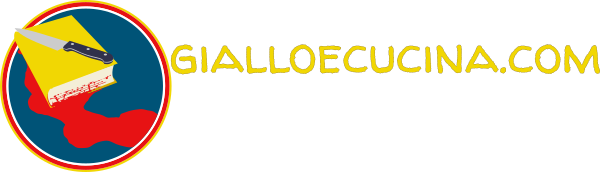Regia di Orson Welles
Film del 1958 con Orson Welles, Charlton Heston, Janet Leigh, Joseph Calleia, Akim Tamiroff, Joanna Moore, Marlene Dietrich
Genere: Noir
A Los Robles, cittadina sul confine tra Stati Uniti e Messico, il capitano Hank Quinlan (Orson Welles) è chiamato a indagare sull’omicidio di un uomo d’affari, saltato in aria insieme alla sua automobile. I suoi sospetti s’appuntano da subito su Manolo, giovane messicano amante della figlia dell’ucciso. Ma l’ipotesi non convince Mike Vargas, alto funzionario governativo incaricato di indagare sul traffico di stupefacenti tra USA e Messico; soprattutto quando costui si convince che Quinlan stia giocando sporco, producendo prove false contro il suo sospetto…
Un noir totale. Così mi piace definire L’infernale Quinlan del maestro Orson Welles. Sì, perché, in questo capolavoro, ogni singolo elemento strutturale è funzionale a veicolare l’inferno che si agita dentro i protagonisti così come fuori, nel contesto in cui vivono.
La mancanza di etica, tema nodale di ogni noir che si rispetti, è infatti corroborata dalle scelte formali, che costituiscono una vera e propria estetica della perdizione: l’uso massiccio e sistematico di inquadrature oblique da basso, ad esempio, ci offre una visione prospetticamente distorta dei personaggi, che riflettono così esternamente le angosce, le ossessioni, il male che alberga dentro di loro; allo stesso modo, le inquadrature fuori asse rendono autentico il senso di precarietà, di pericolo, che si annida in ogni angolo del reale.
Insomma, se il noir è figlio dell’espressionismo, L’infernale Quinlan di Welles è uno di quelli che più somiglia alla madre…
E poi, i personaggi. A cominciare da lui, Quinlan: incapace di alcun controllo, non solo sulla sua condotta morale ma anche sul suo stesso corpo, sfatto dall’abuso di cibo, dall’alcool e dal fumo dell’onnipresente sigaro. Quinlan non parla, ma biascica, borbotta, farfuglia, grugnisce, sbruffa: è quasi la prosopopea di un torpore esistenziale, di una stanchezza psicosomatica, che gli deriva dalla consapevolezza di essere uno dei pochissimi a conoscere le dinamiche marce e viziose del mondo e a saperle affrontare, anche a costo di liberarsi del fardello più gravoso, quello della coscienza. Welles è un maestro alla regia ed è maestro nella recitazione, tanto da riuscire a tratteggiare, senza dire nulla o quasi, uno dei personaggi più controversi, ambigui e “maledetti” della storia del cinema.
Ciliegina sulla torta – marcia e deforme – della realtà narrata da Welles, è la componente grottesca, che, come ci insegna il nostro caro Dante, è indispensabile per rendere autentici gli inferni narrativi: il personaggio di Grandes, ad esempio, tozzo e panciuto, baffetto da sparviero e occhi neri e vivaci da vero messicano, più che un criminale incallito pare un omuncolo avido e viscido come qualsiasi affarista che si rispetti, e i suoi modi sembrano, a tratti, più quelli di una comare acida che di un brutto ceffo.
Ma a Welles non basta mostrarci, per quanto intensamente lo faccia, il suo inferno noir; perché, citando sempre Dante, un inferno, perché si davvero tale, deve offrire a tutti la possibilità di entrarci dentro, senza limiti di tempo, di spazio, di mentalità, di epoche storiche. Ed ecco che, allora, il perno semantico del film si rivela essere, man mano che si va avanti nella visione, un concetto che travalica l’esperienza individuale, che annulla le differenze e ci mette “tutti sulla stessa barca”; un concetto espresso sotto forma di un quesito universale, che riecheggia fino ad oggi dalla notte dei tempi: è lecito porre mano alla giustizia privata se, per quanto intuitiva ed arbitraria, si rivela più efficace e “giusta” di quella pubblica e fondata sul diritto? Ai posteri l’ardua sentenza…