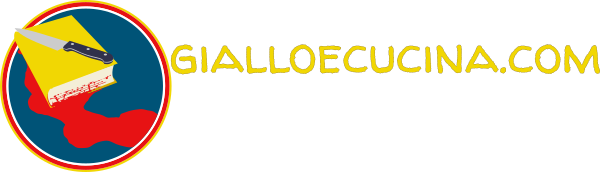Regia di Pupi Avati
Film del 1976 con Lino Capolicchio, Francesca Marciano, Bob Tonelli, Gianni Cavina, Giulio Pizzirani, Vanna Busoni, Pietro Brambilla, Eugene Walter
Genere: Thriller
Bassa Ferrarese, anni ’50. Stefano, un restauratore, si reca in un placido e sonnolento paesino di campagna con l’incarico di recuperare all’usura del tempo un affresco che rappresenta il martirio di San Sebastiano, dipinto sulla parete di una chiesa da Buono Legnani, un pittore pazzo morto suicida molti anni prima. Ma, a parte il signor Solmi, che ha offerto l’incarico a Stefano, l’intera comunità sembra invece voler dimenticare completamente Buono Legnani: tanto più che, oltre alla sua follia e a certe scabrose malelingue, che narrano di presunti rapporti incestuosi tra il pittore e le sorelle, negli ultimi anni della sua esistenza Legnani aveva preso a ritrarre gente prossima al trapasso e si era perciò guadagnato l’epiteto di “pittore delle agonie”.
Leggende di paese, pensa Stefano, ignorando persino gli inquietanti resoconti del suo amico Antonio, anch’egli in paese per lavoro, circa alcune sue indagini sul pittore. Ma una notte proprio lui, Antonio, precipita dal balcone della pensione in cui alloggiava. Da questo momento comincia per Stefano, sempre più ossessionato dalla figura di Buono Legnani e più che mai convinto che Antonio sia stato ucciso, una lenta ma inesorabile discesa tra gli orrori celati dietro la banale monotonia della soporifera provincia rurale. Fino allo sconvolgente, spiazzante finale.
Ci sono film che spaventano e film che fanno paura. Per quanto intenso però, lo spavento dura pochi istanti, è effimero; la paura, invece, resta, si attenua ma non sparisce, si sedimenta nel profondo e, a volte, rimane per sempre. La casa dalle finestre che ridono appartiene senz’altro alla seconda categoria, poiché in grado di lasciare nello spettatore una funesta, atroce consapevolezza: l’orrore è dappertutto, non ha nulla di straordinario e spesso si nasconde, anzi, dietro la più banale e monotona quotidianità.
Nel veicolare tale terribile significato, Pupi Avati si rivela un narratore raffinato ed espressivo nonché un esperto narratologo, capace di rovesciare la semantica di quanto ciascuno di noi associa spontaneamente alla quiete, alla serenità, al Bene, all’ordinario. Un ameno paesaggio campestre si rivela così essere custode di terribili segreti; la purezza e la semplicità della piccola comunità di provincia, dove tutti si sostengono a vicenda e dove certe cose non succedono, nascondono invece un vaso di Pandora, ricolmo del male più perverso, sadico e retrogrado; un dipinto sacro diviene veicolo di una presenza malefica; le persone all’apparenza più fragili e inermi diventano le più malvagie e pericolose.
Ma la pervasività di tali concetti non sarebbe così potente ed immediata senza un adeguato corrispettivo in termini estetici e di forma, raggiunto anzitutto grazie ad un intreccio ben congegnato, dove lo spettatore brancola in un contesto dove tutto è taciuto o, al massimo, bisbigliato, in cui l’inganno e il depistaggio si trovano ovunque, dove le facce pulite, gli atteggiamenti affabili, i sorrisi e le parole gentili non sono altro che un tappeto sotto cui si celano il più disgustoso sudiciume morale, le abitudini più grette e aberranti, la follia più contorta.
Da buon dantista, Pupi Avati vuole trascinare in toto lo spettatore nel suo inferno, e punta a stimolarne la sfera sensoriale oltreché quella mentale ed emotiva: certi personaggi e alcune ambientazioni comunicano analogicamente una sensazione di sporco, di degrado, di squallore estremo, altri rendono quasi fisico il profondo disagio psichico in cui sono costretti, altri ancora appaiono grotteschi, quasi subumani.
La perizia narratologica di Pupi Avati si rivela, inoltre, nel suo saper rielaborare in chiave moderna vecchi e disusati moduli narrativi, da quelli orali della civiltà contadina, con cui gli anziani terrorizzavano i bambini alla sera, davanti al focolare, per educarli, tramite la paura, agli orrori del mondo, a quelli scritti del romanzo gotico. È dalle leggende di paese, dalle storiacce della cronaca locale, che Avati, come egli stesso dichiara, ha pescato a piene mani per plasmare il soggetto del film. Al contempo, le atmosfere e le ambientazioni de La casa dalle finestre che ridono sono squisitamente gotiche: ne è un esempio emblematico la chiesa in cui si trova l’affresco maledetto.
Proprio come le voci di quei vecchi contadini di un tempo, l’orrore resta per gran parte del film solamente sussurrato, non vi sono scene truci o macabre e tutto è affidato alla suspense, alle atmosfere cupe, ai rumori sinistri, al silenzio e alle tenebre. Eccetto che negli ultimi trenta minuti finali: qui il suggerito diviene di punto in bianco palese, l’orrore prorompe nelle sue forme più raccapriccianti, la paura diviene terrore e l’angoscia si muta in uno sbigottimento allucinato e delirante, in un crescendo di violenza e terrore che ha la sua acme nel finale: totalmente inaspettato da risultare assurdo, così traumatico da rasentare lo shock.
Davvero sinistra la colonna sonora. Lino Capolicchio e Gianni Cavina – entrambi da poco mancati… – danno grande prova di sé, contribuendo alla potenza emotiva e semantica di questo capolavoro.
Che dire di più? Correte a vedere – o a rivedere – La casa dalle finestre che ridono: scoprirete quanto sia facile, alle volte, tornare ad essere bambini…