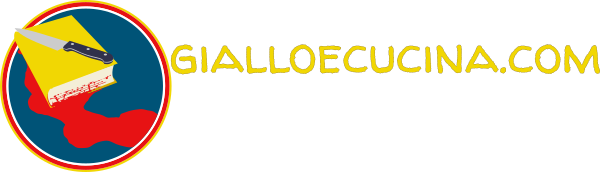Intervista a cura di Claudia Proietti
Diamo il benvenuto su Giallo e Cucina a Carlo Lucarelli che ringraziamo infintamente per la sua disponibilità.
Nel suo lunghissimo curriculum figurano praticamente tutte le declinazioni della narrazione: scrittore, sceneggiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, curatore editoriale e fumettista.
I suoi personaggi sono diventati vere e proprie icone nel panorama letterario e, successivamente, anche in quello cinematografico e televisivo e i suoi approfondimenti sulla cronaca nera sono dei must per chiunque ami l’indagine su fatti e storie.
Oggi, però, nello specifico, parliamo del suo nuovo romanzo, Almeno tu, edito da Einaudi, uscito ufficialmente il primo aprile scorso.
Quella di Vittorio e Paola è una famiglia qualunque che viene devastata dalla morte della figlia adolescente Elisa, investita da un’auto dopo una serata con gli amici. L’incubo di ogni genitore: un figlio che esce e non torna più. Da lì tutto si frantuma e cade giù, come anche la maschera di serenità che questa famiglia indossa, infatti Paola e Vittorio si allontanano. Alla devastazione del lutto si aggiunge qualcosa di ancora peggiore: l’idea che l’incidente che ha portato via Elisa non sia poi così “usuale”, che ci sia qualcuno da incolpare. Da lì, il seme del sospetto, alimentato dal rancore, cresce e non si placa.
CP Nonostante il suo stile sia inconfondibile, e per i suoi lettori affezionati molto familiare, leggendo il libro non ho potuto fare a meno di notare che dalla storia permea, forse per la prima volta, una sua immedesimazione (ovviamente nei limiti) nel personaggio di Vittorio. Immedesimazione che diventa inevitabile anche per il lettore. Come si è sentito, da padre e da uomo, nel compiere questo processo? E, in qualche modo, questo “esercizio” – se così vogliamo definirlo – è stato illuminante?
CL In effetti sì, qui ho cercato di fare una cosa diversa, perché di solito io scrivo – quando scrivo romanzi con i miei personaggi seriali – di investigazione, poliziotti, eccetera. Racconto sempre di persone che non sono io, che mi incuriosiscono proprio perché sono lontane da me. Quindi il commissario De Luca è un signore di cui sono curioso di vedere cosa fa, mi ci confronto, ma non sono io.
Qui invece volevo fare una cosa diversa, cioè prendere delle cose mie intime: paure, fragilità, e darle al mio personaggio. E quindi c’è, in effetti, un’identificazione molto più stretta. Io ovviamente sono diverso, per fortuna non mi succedono quelle cose, ho due bambine meravigliose e non ho mai avuto problemi. Però, lo stesso, ho voluto prendere proprio cose mie – appunto paure – e darle a lui per vederlo non più da fuori, ma quasi da dentro. Ed è stata un’identificazione che, in effetti, mi ha dato fastidio; è stato molto doloroso. Ho fatto fatica a scrivere questo libro. Non so perché, volevo scrivere una roba che facesse male, che mi facesse male. Non so perché, ma volevo scrivere così, e il risultato è questa storia.
In tanti momenti in cui scrivevo molte di quelle cose, che erano mie, le sentivo in maniera molto forte e mi dava fastidio.
CP Tra i vari messaggi contenuti nella storia, traspare quello che riguarda la difficoltà, anzi, possiamo definirla l’impossibilità, di conoscere totalmente i propri figli e, in generale, le persone che amiamo e che, in un certo senso, diamo per scontate dal punto di vista comportamentale. Soprattutto si analizza la totale incapacità di prevedere le loro azioni e comprendere davvero in che modo i nostri atteggiamenti, che siano essi severi, protettivi o permissivi, possano essere da loro recepiti e assimilati.
Anche perché, di solito, nell’intento di non voler ripetere comportamenti che abbiamo subito, rischiamo di fare anche peggio.
Lei crede esista un modo o un atteggiamento adeguato di interfacciarsi coi ragazzi? E se sì, quale?
CL Non lo so, o meglio, qualche idea ce l’ho, però premetto che non sono un esperto né di genitorialità (se non di quella che vivo in prima persona), né di rapporti fra generazioni, tra genitori e adolescenti, o cose così. Il mio è un punto di vista umano e quello di uno scrittore che ha vissuto dentro un personaggio, per cui una considerazione molto personale.
Io credo che ci sia un modo di fare diverso, che non consiste né nel replicare quello che ci è successo, né nel controllare ciò che succede, ovvero stare di fianco.
Capisco che è impossibile sapere che cosa pensano i nostri figli, conoscere esattamente gli adolescenti, per esempio. Ovviamente gli adolescenti sono sempre “gli adolescenti” nella storia dell’umanità, però tutte le volte si confrontano con un mondo diverso; quindi, la mia adolescenza non può essere quella delle mie due bambine. E non solo. Io non posso pretendere di capire esattamente quello che pensano, quello che fanno; non posso pretendere di conoscere cosa è sbagliato o negativo, di proteggerle al cento per cento, perché vivono in un mondo che non è il mio, con parametri che non sono i miei e che io non posso comprendere fino in fondo. Però li posso osservare.
Ecco, credo che la chiave di tutto sia la presenza. Io guardo le mie figlie per come le vedo, non sto lì a interpretare esattamente cosa pensano, per esempio, quando guardano un film. Di recente abbiamo guardato insieme un horror giapponese piuttosto violento; io non sono di certo il tipo che dice “non guardate certe cose” – come dicevano a me quando ero piccolo – ma sono lì, con loro due, sono lì a guardare anch’io. Non sempre, ovviamente, però in quel momento ci sono, sono seduto con loro, e voglio confrontarmi.
Credo sia il confronto la chiave.
Ci si pone di fianco, mai al di sopra, anche perché loro sono molto più avanzate di me, anche sulla percezione di concetti importanti, come i diritti civili, per esempio. Stanno vivendo in un mondo che è diverso da quello in cui vivevo io. Non hanno i miei pregiudizi, da un certo punto di vista sono più in gambe, più intelligenti; quindi, non mi ci metterei mai al di sopra. Però di fianco sì, perché non esserci significa lasciar andare e, da lì in poi, può succedere qualunque cosa. Esserci, al contrario, significa osservare e poter intervenire, almeno nei limiti in cui si può intervenire.
CP Proprio restando sull’argomento “giovani”, negli ultimi tempi si sta cercando, sempre più disperatamente, di intercettare i loro pensieri e le loro emozioni (soprattutto quelle inespresse), nell’ottica di evitare che poi – come purtroppo quasi quotidianamente vediamo – esplodano in gesti irreparabili di violenza. Si ritiene che tutto questo dipenda da una serie di fattori che coinvolgono, famiglia, scuola, società. Lei crede che questa incapacità di esprimersi sia figlia dei nostri tempi o che ci sono solo più elementi di distrazione che ci impediscono di comprendere i nostri figli?
CL È figlia dei nostri tempi solo in parte. Mi sono occupato tante volte di vecchi delitti; curo una rubrica su La Repubblica per realizzare la quale faccio ricerche. Ho una specie di “prateria di caccia” per questi fatti: le raccolte delle pubblicazioni delle riviste specializzate in cronaca nera della fine degli anni ’40 e ’50, ovvero l’immediato dopo guerra, che era pieno di queste pubblicazioni. Erano riviste di nera, si chiamavano “Polizia scientifica”, “Crimen”, giusto per citane alcune, ed erano un po’ l’equivalente dei programmi che vediamo adesso in televisione, quelli true crime (successivamente sono state sostituite dalle riviste di gossip).
Sono andato a sfogliare queste riviste e c’era davvero di tutto, succedevano un sacco di cose che sono le stesse che succedono adesso; per esempio, gli omicidi, quelli senza senso, quelli dei giovani, dei bambini, degli adolescenti.
Abbiamo visto di recente la seria televisiva “Adolescence” e magari pensiamo che un caso del genere sia figlio di cose come i social, il Covid, il lockdown. No, negli anni ’47-’48, il periodo in cui ho indagato io, era lo stesso così; notizie di bambini di 13 anni che hanno sterminato intere famiglie, o ammazzato persone, ce n’erano anche allora. Non siamo cambiati da quel punto di vista, però sono cambiate le condizioni. Allora era diverso: altri mezzi, un altro mondo con cui confrontarsi; adesso c’è questo mondo, quindi io non direi che gli adolescenti di adesso, i ragazzini, sono diversi da quelli di una volta. Quelli che fanno delle cose brutte le fanno per gli stessi motivi probabilmente, le fanno solo in un modo diverso perché hanno altre opportunità.
Di sicuro l’assenza, o la distrazione, delle tre figure che servono e che sono quelle che si occupano di ragazzini – società, famiglia e scuola – è sempre il problema. La scuola e la famiglia soprattutto; le mie figlie escono di casa alle otto e stanno a scuola, dopodiché rientrano e sono in famiglia, poi vanno fuori e ci sono gli amici; ma sono la scuola e la famiglia che formano l’ambiente più interno. E quando queste due realtà sono distratte, che sia il 1947 o il 2025, succedono disastri.
Mi sono documentato anche sul bullismo. Nel 1950 c’era una concretezza, una vicinanza molto più forte anche in quello; chi ti bullizzava era il bambino che stava seduto con te a scuola e ti toccava o ti diceva qualcosa, magari fuori in strada il contatto era ancora più diretto. Adesso invece, puoi essere bullizzato da un signore di cinquant’anni che sta in Cina, per esempio, però il problema rimane sempre lo stesso. Una volta lo sconforto del bambino, la sua reputazione che veniva lesa nella strada (perché lì viveva) gli provocava una crisi e poi magari si suicidava perché gli avevano detto cose brutte. La strada in cui vivono i bambini oggi è il web, è virtuale, però in fondo è la stessa. Abbiamo trasportato la nostra “ansia da reputazione”, a una piazza virtuale ancora più grande, enorme. Sono solo le proporzioni che sono cambiate e che, ovviamente, hanno ampliato il pericolo, questo sì.
Aldilà della strada in cui vivevo io da bambino non c’era niente. Adesso le mie bambine vivono nel mondo. Ecco, è lì che dobbiamo darci da fare noi. E questo non significa diventare un hacker o un esperto di informatica. Devo sedermi lì di fianco e farmi spiegare le cose. Che poi è quello che ho fatto per il libro. Molte delle cose che ho messo nella storia, i cosplayer o i Furry, me le hanno spiegate loro. È il loro universo; io avevo una micro-idea, tipo, “mi piacerebbe metterci un cosplayer”. Allora mia figlia Angelica è arrivata e mi ha istruito per bene, e così ho capito anche cosa fa lei, visto che è una cosplayer. Ho capito cosa c’è dietro, che c’è chi lo fa bene, chi lo fa male eccetera.
CP Il tema dei social e del mondo virtuale, così tentacolare e pericoloso, è preponderante. L’inganno rappresentato da una chat o da un social media è un inganno che si riceve e, al tempo stesso, si può compiere. E questo, nello specifico, non riguarda solo i giovani, perché ci cascano anche gli adulti. Secondo lei, c’è un modo per “schermarsi” da questa apparenza ingannevole?
CL Il problema è proprio quello, io credo, e non è facile da risolvere. “Non ti tocco ma arrivo a farti del male”, è una questione generazionale e ci penso spesso.
Se qualcuno mettesse una mia fotografia imbarazzante o compromettente sui social, non me ne fregherebbe proprio niente. Se trovassi dei post che mi attaccano e dicono che sono non so chi, a me non interesserebbe più di tanto; quella non è la vita, per me, quello è un social. Mi scrivi che sono un ladro? Fai pure. Ti querelo e poi finisce lì. Non andrò in giro mascherato perché ho paura.
Il problema vero è quando, invece, quello diventa il mondo “vero”. È su quello che bisogna schermarsi. Se il mondo virtuale diventa quello reale – o magari già lo è e sono io a essere vecchio a parlare ancora di concretezza – qualcosa non va. Se uno scrive, per esempio, che io sono un ladro su un post e io ne soffro come se me l’avesse detto in faccia, è lì che, secondo me, dobbiamo capire e correre ai ripari. Quella è la schermatura necessaria. Occorre saper differenziare, che è poi il problema delle fake news e tutto il resto. Le mie bambine conoscono un sacco di cose, molte di più di quelle che conosco io e che conoscevo una volta.
Spesso mi capita di dire “Sapete che…” e loro rispondono “Ma certo!” e mi mostrano tutto quello che hanno visto su TikTok, in giro, sui social. Gli manca, però, la capacità di distinguere, la tara. Ogni tanto una di loro mi viene a dire “Ma lo sai che è successo questo?”, “Dove l’hai visto?”, “L’ho visto lì”, “Aspetta, io so che non è vero”.
Ecco, è la capacità di differenziare, il senso critico, che dobbiamo dargli. Noi viviamo in un mondo più concreto, abbiamo il compito di insegnargli il senso della concretezza, dargli lo strumento. Alla fine è tutto lì: la presenza, stare di fianco significa dare un esempio, magari anche attraverso una discussione.
CP Nel suo romanzo la vendetta è un elemento sostanziale, affrontato con grande lucidità ma anche con una certa empatia per le motivazioni umane più profonde. Che poi è esattamente il modo in cui ognuno di noi un po’ la percepisce: da un lato c’è la consapevolezza di quanto la vendetta sia distruttiva e sterile; dall’altro, però, spesso affiora anche una comprensione – seppur critica – per quella spinta istintiva che capita di provare di fronte a crimini efferati. Esiste, secondo lei, una forma di giustizia che possa accogliere entrambe le dimensioni, quella razionale e quella emotiva?
CL Questo non lo so, in generale partiamo dalla regolazione dei conti che è un sentimento, una sensazione più o meno precisa.
Per scrivere il libro ho guardato parecchi revenge movie. Ce ne sono un milione. Certi – direi quasi il 90% – sono bruttissimi e molto simili: arriva un tizio e fa un danno proprio a uno che era nella CIA, un agente speciale, ed è caos; altri sono bellissimi, come per esempio “Un borghese piccolo piccolo”, anche il libro ovviamente. La molla che ci spinge a guardarli è sempre la stessa: ci identifichiamo in quello che è stato bullizzato e ci piace quando i “cattivi” capiscono che hanno dato fastidio alla persona sbagliata, quella molla è la resa dei conti. Hai ucciso il cane di John Wick? Bene, hai beccato la persona sbagliata, adesso vedrai. Dopodiché parte il film e li ammazza tutti. Quello è il momento di massimo godimento.
Ci identifichiamo perché tutti noi siamo sempre stati, in qualche maniera, oggetto di ingiustizia, di bulli, e, in quel momento, ci sentiamo appagati, è la nostra vendetta.
È una cosa sbagliata, ovviamente, non funziona così.
Nel mio romanzo ho cercato di fare proprio questo: una cosa sbagliata. Vittorio fa le cose sbagliate, si sta vendicando per il motivo sbagliato e quindi la sua è una vendetta che non esiste. Scende all’inferno senza motivo, ma dopo da lì non esce più. Il suo è un modo sbagliato di reagire a una perdita: dare la colpa a qualcuno quando poi la colpa ce l’ha lui. In questo romanzo di tutte le cose sbagliate che fanno i ragazzini, gran parte della colpa è proprio dei genitori. Il suo è un modo per non dover accettare il fatto di essere il responsabile, così come lo è incolpare altri.
La vendetta, più o meno, è questo: dare la colpa a qualcuno e assicurarsi che la paghi, quando, invece, esiste la giustizia, che però è un altro discorso.
Io, a dir la verità, non empatizzo con il mio personaggio, pur essendoci dentro, non lo giustifico, non penso abbia fatto bene, anzi, come dicevo, tutti nella storia fanno delle scelte sbagliate.
CP In una recente intervista lei ha dichiarato che per la creazione di questo romanzo non si è ispirato a nessun caso di cronaca in particolare perché, purtroppo, sono troppi i casi simili da cui poter prendere spunto. Qual è stato il processo creativo specifico di questo romanzo? C’è stata solo immedesimazione o anche progettualità?
CL No, è stata proprio l’immedesimazione. Io di solito scrivo così, senza sapere quello che succederà. Si dice sempre che ci sono gli scrittori “architetti” e gli scrittori “giardinieri”. Gli architetti pianificano, i giardinieri segnano. Io sono giardiniere. Anche in questo caso avevo chiaro fino al punto in cui lui sogna la bambina, era la parte che sapevo, di quel che succede dopo non ne avevo idea. Cosa avrebbe fatto, quali erano i punti deboli dei ragazzi e se ce n’erano; ci sono arrivato lanciandomi e cercando di entrare dentro. Quando sono entrato dentro, ho cominciato a capire cosa succedeva e, tutte le volte, mi veniva in mente qualcosa che mi stupiva, diverso da quello che pensavo; e sono contento sia andata così. Questo è il mio metodo e qui lo è stato ancora di più del solito: mi interessava stare dentro la testa di un personaggio e vedere dove andava, dall’interno però, mentre invece di solito sto di fianco e vedo – magari insieme a lui – dove stiamo andando. Questa volta è stato diverso e, per fortuna, sono riuscito ad arrivare in fondo.
CP Tutti la stanno leggendo e, appena finiranno, si chiederanno: a quando la prossima storia? Cosa bolle in pentola?
CL Di romanzi adesso ho un po’ di idee, ma adesso aspetto perché è appena finito questo, ci vuole un po’ prima che scoppi un’altra idea. Poi stiamo esplorando altre fiction da sceneggiare; inoltre sto seguendo sempre le narrazioni dei podcast, anche con Massimo Picozzi.
Però di romanzi, nello specifico, non ancora. Ho tre o quattro idee, vediamo qual è la prima che esplode o magari ne viene fuori una totalmente diversa. Si vedrà.
CP Ed eccoci all’ultima domanda, che è anche una speranza: la rivedremo presto in TV con qualche nuovo progetto? Anche perché, tra i tanti casi che lei ha trattato, di alcuni si sono scoperte nuove cose che si potrebbero approfondire. E chi meglio di lei per farlo?
CL C’è il desiderio, quello sì. Mi piacerebbe soprattutto aggiornare e riraccontare alcuni casi. Ustica, per esempio, l’ho raccontato quindici anni fa, oppure Bologna; potrei farci un’altra puntata solo su quello che è venuto fuori dopo. Ma per adesso purtroppo non c’è. Tutti gli anni, ogni tanto, salta fuori, o dalla RAI o da parte mia, un’idea e si concorda che sì, si potrebbe fare, è un bel progetto, però il budget per quell’anno è già esaurito, allora magari ci pensiamo l’anno prossimo e così via. Per cui non lo so, prima o poi ci incastreremo e qualcosa verrà fuori.
CP Grazie mille a Carlo Lucarelli per essere stato ospite di Giallo e Cucina e grazie per tutto quello che negli anni ci ha insegnato, sempre con gentilezza e preparazione.