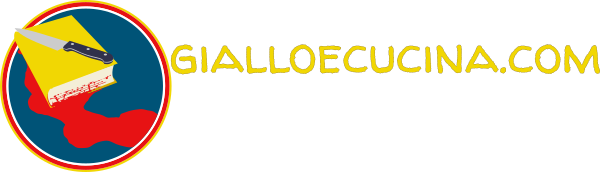Intervista a cura di Claudia Proietti
Benvenuto su Giallo e Cucina.
Ferdinando Salamino è docente e formatore senior in psicologia clinica presso l’Università di Northampton nel Regno Unito. Ha gestito master in terapia familiare sistemica e in counselling a bambini e adolescenti. Dirige, insieme alla professoressa Elisa Gusmini, un team di Systemic Family Therapy per Broad Horizons, un centro di psicoterapia in collaborazione con i servizi sociali nell’area delle Midlands inglesi. È autore, con Valeria Ugazio ed Elisa Gusmini, di diversi saggi pionieristici sulla teoria delle polarità semantiche, sugli slittamenti psicopatologici della personalità e sul passaggio da “attaccamento” ad “appartenenza” nel lavoro terapeutico con le famiglie adottive. Contestualmente, dal 2019, la sua produzione letteraria si è estesa ai romanzi; alla trilogia (edita da Golem Edizioni) del tormentato Michele Sabella (Il kamikaze di cellophane, Il margine della notte, Blues per i nati senza un cuore), è seguito il romanzo breve Gancio largo (Saga Edizioni), spin-off dei precedenti.
Ferdinando Salamino torna, adesso, con una nuova storia e nuovi personaggi. Il suo ultimo romanzo Identità Negate segue le vicende che ruotano attorno alla figura di Ivan Castelli, un criminologo che ben conosce le dinamiche più oscure dell’animo umano e che ha imparato a camminare con il Male al suo fianco. Ivan è un personaggio molto criptico; viene da pensare a lui come a un muro di gomma foderato di chiodi, perché non solo possiede la controversa abilità di respingere il più lontano possibile chi ci si scontra, ma riesce, al tempo stesso, a ferire chi entra in contatto con lui. In questo suo essere così ruvido e inospitale per gli altri, Ivan si trova a dover affrontare un lutto, forse il più estremo: la perdita della figlia appena diciottenne Nadia, la quale viene trovata una mattina priva di vita, con evidenti segni di violenza sul corpo, dopo una festa nella villa di proprietà del suo migliore amico, Edoardo De Meo, ragazzo introverso e problematico che appare subito agli inquirenti come papabile colpevole. Ivan decide di collaborare con la difesa di De Meo mettendo avanti alla voglia di giustizia la sua implacabile sete di verità. Il suo percorso è collaterale alle indagini del procuratore Sonya Tagliaferri, che è anche una sua ex fiamma, e del vicequestore Marini. Il criminologo approfondisce le dinamiche che ruotano non solo attorno alla scomparsa della figlia, ma anche all’ambiente di Edoardo De Meo, in particolare la famiglia, per scoprire via via delle situazioni del tutto inaspettate e inquietanti che condurranno alla verità. Una verità che non riporterà Nadia in vita, ma che permetterà finalmente a Ivan di togliere almeno qualcuno dei chiodi di cui le pareti del suo cuore sono corredate, per affrontare finalmente il dolore.
CP Questo romanzo è, come tutti gli altri tuoi, un viaggio attraverso i corridoi più intricati e più cupi dell’animo umano. Già il titolo suggerisce una riflessione su quella che è la disgregazione dell’Io, la perdita dell’identità che non viene accettata per quella che è a causa di fattori sociali e/o culturali. Tale perdita, però, non riguarda soltanto il colpevole ma è prerogativa un po’ di tutti all’interno del romanzo, a partire – ovviamente – dalla figura ombrosa di Ivan Castelli, passando anche per gli altri personaggi. La Tagliaferri ha già perso parte di sé stessa nel corso della vita; Glenda, l’infelice moglie di Ivan, ex modella, ha rinunciato alla carriera, e persino Nadia, nel tentativo di sopravvivere prima a due genitori che non si amano, e poi all’adolescenza, perde inevitabilmente la sua parte innocente in cerca di qualcos’altro con cui sostituire la propria fragilità. Inoltre, c’è Edoardo De Meo, che possiamo definire forse il più smarrito di tutti in questo clima di perdita e di rifiuto.
Ecco, quanta importanza ritieni che abbia mantenere integra la natura della propria identità – di qualunque identità si parli – al livello individuale, sociale, ma soprattutto familiare? E può, secondo te, la tutela di questa identità, arrivare a essere, in qualche modo, nociva per quelli che sono i “ruoli” sociali e, nello specifico, familiari?
FS Questa è una domanda di ampio spettro a cui cerco di darti la mia risposta. Io penso che il mantenimento dell’identità sia un compito essenziale, proprio della nostra specie, ciò che ci contraddistingue come umani. Siamo gli unici esseri che noi sappiamo – almeno gli studi che abbiano hanno permesso di capire che, finora, siamo le uniche creature dotate di autobiografia, visto che ci auto-narriamo di continuo – che in qualche modo hanno bisogno di raccontarsi ogni giorno la storia di sé stessi per “recuperarsi”. Nei malati di Alzheimer, per esempio, non è tanto la perdita della memoria in quanto tale il problema, ma il fatto che, mangiandosi la memoria, la malattia si porta via anche l’identità, che è l’aspetto doloroso anche per il sistema familiare. Per l’individuo l’identità è una sorta di marchio, un brand di noi stessi che portiamo avanti. Questa difesa dell’identità, a volte, è estremamente fluida: ci sono famiglie che supportano l’identità individuale, che quindi aiutano ciascuno a crescere come individuo, così come ci sono contesti sociali molto supportivi; ma ci sono spesso anche attriti tra l’identità individuale e i contesti sociali, identità scomode per la società che spinge l’individuo a una scelta che può essere o di totale sottomissione – pensa a tutti gli attori, per esempio, omosessuali che per anni hanno finto di essere etero e hanno fatto il coming out in punto di morte (tipo Rock Hudson per citarne uno di cui si è parlato tanto) – o c’è il tentativo di compromesso, dove si cerca di trovare una via di mezzo tra queste identità. Poi c’è la scelta della totale rottura, la ribellione rappresentata dallo scegliere la propria identità anche a scapito di una posizione sociale.
In un certo senso nel romanzo tutti quanti i protagonisti vengono chiamati a fare questa scelta: le loro identità sono in gioco e ciascuno risponde a questo dilemma in un modo personale. La risposta di Ivan è molto diversa da quella di Sonia, che è molto diversa da quella di Edoardo. Nadia forse è il primo personaggio che vediamo rivendicare, con una certa verve polemica e ribelle, la propria identità.
CP Tutti i tuoi romanzi si addentrano nelle ombre, non solo dei personaggi di cui racconti, ma della società in cui questi personaggi vivono (la nostra società). Vengono affrontati temi come l’emarginazione, la violenza domestica (non solo intesa come percosse et similia, ma anche coercizioni psicologiche ed emotive) e la disperazione. Quest’ultima diventa per alcuni una sorta di passe-partout per abbandonarsi o alla pazzia o alla criminalità o alla depressione. Nell’esplorare contesti così dolorosi c’è, da parte tua, un tentativo di decodificarli per tentare di espiare le colpe della società? O, almeno, di dare strumenti ai lettori per affrontare tali tematiche nel caso in cui si presentino nella vita reale di tutti i giorni?
FS Come molti dei miei personaggi, anche io conducono due vite: quella dello studioso, del ricercatore, del terapeuta e quella dello scrittore/cantastorie. Cerco di ricordarmi sempre quale vita sto vivendo in quel momento; se sono Bruce Wayne o Batman, perché sono vite che hanno regole molto diverse. Quando voglio educare, lanciare un messaggio che sia chiaro e che non debba essere frainteso, la mia strada è quella della ricerca scientifica: lavoro sui dati, porto evidenze e metto le persone davanti a realtà che sono, appunto, decodificate. Quando scrivo, invece, ho una grande paura di lanciare messaggi, perché mi sembra sempre che i “libri-messaggio” siano tremendamente noiosi. Ci sono queste tesi urlate a tutto spiano, che poi è anche un po’ il problema della narrativa contemporanea in generale, non soltanto narrativa scritta; lo storytelling è diventato quasi un voler propagandare un messaggio, a volte magari anche un messaggio giusto, ma propagandato in un modo che lo rende noioso, da cui poi il lettore – o lo spettatore – si disaffeziona. Quando scrivo, in realtà, cerco di raccontare una storia che, come dici, affonda nelle ombre della società, perché in fondo è lì che mi sembra stiano le storie che vale la pena di raccontare. Le storie che scrivo sono sempre quelle che vorrei leggere; quindi, un libro che non interroga la società è un libro che tendenzialmente mi interessa poco; il punto, per me, è interrogare più che rispondere. L’altra sera, durante una presentazione, parlavo del motivo per cui scrivo il noir: io uso il noir e il thriller per mettere i punti di domanda dove noi spesso noi, come società, mettiamo dei punti esclamativi. Il punto di esclamativo per eccellenza è che “i genitori amano i figli in modo incondizionato e totale”; è un punto esclamativo su cui si regge molto della nostra impalcatura sociale. Tuttavia, la realtà ci dimostra che anche questo è un punto interrogativo; non è sempre così, non tutti i genitori amano i figli o li amano incondizionatamente, alcuni li amano alla follia ma ne amano una proiezione che in realtà è un loro desiderio ed è su questi interrogativi che io cerco le mie storie e trovo i miei personaggi.
CP In Identità negate, come nel caso (ormai relativamente recente) della serie TV di successo Adolescence (Netflix), emerge un’esigenza che, in età adulta – soprattutto se genitori – avvertiamo: riuscire a comprendere, o almeno a intercettare, pensieri ed emozioni dei più giovani, spesso impossibili da decifrare, in un’epoca in cui tutto è “a portata di click” ma molto meno “a portata di anima”. In una recente intervista, Carlo Lucarelli, in merito al suo ultimo romanzo Almeno tu (che tratta l’incapacità di conoscere i reali stati d’animo e le fragilità dei propri figli), ha dichiarato che, a suo avviso, bisognerebbe evitare di giudicare con saccenza i ragazzi, camminandogli né troppo avanti né troppo indietro, ma accanto, disposti a imparare da loro, ma sempre pronti a essere guida, a chiarire eventuali dubbi. Sei d’accordo? Come ti poni da padre e da professionista riguardo a questo argomento?
FS Essere in disaccordo con Lucarelli è sempre una questione delicata; tuttavia, penso che non sia corretto perché credo che non ci sia una strada giusta per un genitore. La mia visione, un po’ più pessimista, è che il genitore sia condannato a fallire dovunque scelga di mettersi, perché il suo è un paradosso impossibile: lui cerca di proteggere il figlio o la figlia dal mondo, almeno, come abbiamo detto nella migliore delle ipotesi, quando davvero ama suo figlio, preparandolo per il mondo. Il problema che tutti i genitori, di tutte le generazioni, hanno sempre avuto – e avranno sempre – è che il mondo da cui noi proteggiamo i figli, e quello per il quale li stiamo preparando, è il nostro, quello che abbiamo imparato a conoscere; ma, nel frattempo, tutto è già cambiato. Noi prepariamo i nostri figli a sopravvivere a un mondo che non esiste più, che è quello in cui noi esistevamo ma che ha già regole nuove, diverse.
La grande profondità della serie Adolescence è che tu spettatore, fino all’ultimo, aspetti di vedere il papà abusante o la violenza domestica; invece, questi due genitori sono bravissime persone che hanno soltanto commesso un errore: quello di illudersi che, una volta che il loro bambino era nella sua stanza, il loro lavoro di proteggerlo forse era finito, perché nel mondo in cui vivevano loro i pericoli stavano tutti fuori da quella stanza. Il mondo in cui, però, il loro figlio è cresciuto (ed è diventato quello che è diventato) è un mondo dove i pericoli stanno nel cellulare, nel tablet, nei podcast, nei video di Andrew Tate che, su TikTok, ti dice che il maschio Alfa deve fare questo e quest’altro. Sono messaggi estremi che stanno anche in certe aggressioni di un femminismo estremo che ti dice che qualunque comportamento maschile è di per sé tossico. Il pericolo risiede in quest’area dove ci si è così polarizzati che non si può più essere critici e cercare mediazioni, perché altrimenti si sta dalla parte sbagliata.
Il lavoro del genitore non finisce quando tu li metti a letto; in teoria lì comincia. Ma cosa si può fare?
Ecco, penso che il genitore, che cerchi di stare un passo avanti, indietro, di lato, sopra o sotto sia comunque sempre a rischio di perdere di vista i figli. Loro crescono un po’ nonostante noi, un po’ grazie a noi perché quello che – credo – salvi, a prescindere dalla posizione dove ci mettiamo, è l’amore e la comunicazione. Se ci sono davvero amore e comunicazione, anche se commetti un errore, quell’errore è rimediabile e, in qualche modo, si può crescere insieme. I Beatles avevano più ragione di quanto pensassimo quando cantavano “All you need is love”: quel che, in realtà, servirebbe è che il figlio sapesse di poter sempre accedere alla comunicazione. A volte ci siamo ma siamo chiusi; anche nel caso di Ivan e Nadia, lei amava suo padre ma non sentiva di potergli parlare e questo è un bel muro. L’amore deve essere aperto.
CP Dovendo attribuire un genere specifico alle tue opere, verrebbe da pensare al termine “Noir psicologico”; c’è l’elemento di suspense tipico del thriller, c’è l’indagine legata a un mistero da risolvere, quindi il giallo, ma principalmente – abilità che tu sei solito dimostrare – c’è un vero e proprio tour guidato del nero che abita ciascuno di noi. Quali sono i tuoi modelli letterari, le fonti d’ispirazione e i maestri che ti hanno formato, prima come lettore e poi come scrittore, per generare questo specifico tipo di narrazione?
FS A volte cercare di rispondere a questa domanda ti rimette in contatto con parti dimenticate. Se io dovessi pensare al primo nome che mi viene in mente quando penso a un modello letterario che mi ha plasmato come lettore, e, quindi poi ovviamente come scrittore, ti direi subito Dostoevskij, in particolare il Dostoevskij di Delitto e Castigo che è stato un po’ il mio romanzo angolare, quello che ha anche definito gli assi morali sui quali si snoda la mia narrativa. Poi ho tantissimi autori che ho amato; per l’aspetto dello stile Cormac McCarthy, di cui ho amato tantissimo Meridiano di sangue nonostante racconti una storia di violenza inaudita; oppure Soffocare di Chuck Palahniuk, con la sua capacità di mettere il lettore di fronte a dei paradossi fulminanti. Inoltre, penso che non diamo mai tantissimo credito a Stephen King perché lo si vende ovunque, anche al supermercato, ma ha sempre avuto una gestione della suspence e del voltapagina che è mirabolante; adesso un po’ di meno, ma ai tempi d’oro della sua ispirazione massima, non riuscivi proprio a metterlo giù un suo libro.
Tuttavia, ripensando ai miei personaggi, sia Ivan che è l’ultimo della carrellata, ma anche Michele della prima, alla fine mi accorgo che hanno sempre un dilemma tra giustizia e legalità, come se si trovassero al bivio a dover decidere se seguire la legge o un’idea di giustizia più al di là dell’applicazione del codice penale; ecco, penso che questo mio aspetto richiami tantissimo l’amore che ho provato per l’Antigone: questa meravigliosa tragedia dove c’è il dilemma dell’individuo sul seguire la legge o fare la cosa giusta. In un certo senso tutti i miei protagonisti si trovava a dover rispondere a questo interrogativo. La giustizia privata ovviamente dipende anche da chi la legge; può sembrare quasi più giusta di quella pubblica, però a quale prezzo? In un certo senso è un interrogativo a cui ogni risposta che tu cerchi di dare, ti riporta al punto di partenza.
CP Un tuo lettore arriva a supporre che la tua carriera professionale abbia indubbiamente contaminato quella letteraria, immaginando che esse si influenzino a vicenda. È così? E ti è mai capitato che, oltre all’esperienza clinica a nutrire la narrazione, avvenisse il contrario? Ovvero che la scrittura fosse input di interesse per il tuo lavoro accademico?
FS Sicuramente sì, anche perché come terapeuta il mio lavoro è ascoltare storie, smontarle e poi rimontarle insieme alle famiglie con cui lavoro; in un certo senso quindi – almeno nel modo in cui faccio io terapia – non puoi fare terapia se non ami le storie. È un modo di lavorare che è molto narrativo e che ha una grande influenza anche sul mio modo di scrivere. Però è vero anche il contrario: a volte mi è capitato di ascoltare pazienti, magari scrivere un punto di vista che mi ha fatto pensare proprio a situazioni che erano nate nei miei romanzi, ovviamente senza l’aspetto criminoso. Insomma, i dilemmi individuali che riecheggiano, quelli che magari i protagonisti hanno dovuto affrontare in questo quel romanzo, formano un circolo che mi piace pensare virtuoso, un cicolo di creatività. Penso la terapia aiuti molto a scrivere storie, magari che abbiano dei punti di vista un po’ divergenti; poi lo stile di scrittura e la capacità letteraria aiutano raccontare poi meglio anche le storie che racconti in terapia.
CP Per quanto riguarda la percezione delle cose da parte della psiche umana, che è una delle tue principali aree di studio, restringendo il campo alla scrittura (ma anche alla lettura) di un romanzo, tu credi a quello che tanti dicono, cioè che la scrittura possa avere una valenza terapeutica per l’autore? E quanto questo atto catartico può avere un riscontro reale sul lettore?
FS Penso che tutto può avere una valenza terapeutica ed è una cosa in cui credo molto. Non tutte le persone devono risolvere i problemi andando dallo psicologo; c’è chi lo fa facendo kitesurf, chi parte, chi fa marziali, chi medita e, probabilmente, c’è chi riesce a trarre dalla lettura quel senso di ispirazione anche per cambiare la propria vita. Non credo però si possa mai prescrivere la lettura come terapia; spesso mi capita, nei gruppi di lettura che ogni tanto frequento, di trovare utenti che scrivono “datemi un libro che mi aiuti a superare la crisi matrimoniale”; ecco, io non penso che si possa istruire una persona in questo modo, credo che le storie che noi accogliamo quando leggiamo un libro, i protagonisti e i personaggi che abbracciamo col nostro sguardo quando leggiamo, possano ispirarci, magari anche farsi portatori di messaggi che fino a quel momento non erano ascoltati, anche messaggi che arrivano da parti profonde di noi stessi e che – in qualche modo – aspettano lì “in giacenza” di essere ascoltati. A volte quei messaggi vengono sbloccati da una lettura che non si può fare in modo prescrittivo, ma che assolutamente può essere di grande conforto. Succede anche a me come autore; sembra strano dirlo, perché i miei libri sono ritenuti spesso molto feroci, molto crudi, ma io li trovo consolatori rispetto alla realtà, perché comunque c’è un motivo, mentre spesso molte tragedie a cui assistiamo nel mondo reale restano senza motivo, senza movente, senza spiegazione. Nei miei noir alla fine una soluzione c’è, anche se magari non è una soluzione sempre felice, le cose hanno senso per quanto mi riguarda, sia come lettore che come scrittore; la lettura e la scrittura servono a dare senso alle cose.
CP Nella trilogia di Michele Sabella esplori il tema della malattia mentale, intesa non soltanto come mero disturbo ma come una sorta di filtro, una lente particolare attraverso la quale il protagonista (e non solo) vede e reinterpreta la realtà. Nel delineare un personaggio che lotta contro la malattia, ma allo stesso tempo rincorre la verità oggettiva, cosa volevi dimostrare? Qual era il tuo obiettivo durante l’iter di creazione di una figura così ambivalente?
FS Hai colto un aspetto fondamentale del mio modo di raccontare la malattia mentale. Almeno nella storia, che è una visione contestuale, cerco di spiegarmi quello che noi chiamiamo “malattia mentale”: come un punto di vista sul mondo che noi definiamo “malato” perché incompatibile con alcune regole e infrastrutture sociali. Che poi, se tutti dovessero funzionare allo stesso modo probabilmente non potrebbero esistere certe malattie, ma se trasportiamo determinati disturbi in un contesto diverso, essi assumono un’altra valenza. Chiaramente nella nostra società occidentale, pragmatista e orientata molto all’individuo come “capitano del proprio destino”, qualcuno che parla da solo o sente delle voci che lo guidano dall’esterno è considerato una figura folle, però, in culture sciamaniche per esempio questa capacità di ascoltare “le voci dell’invisibile” è una qualità per cui si viene riveriti.
La malattia mentale è un punto di vista sul mondo che volevo raccontare. Con Michele non avevo voglia di istruire nessuno su qualcosa, mi piaceva l’idea di immaginare cosa succederebbe se, in qualche modo, un ragazzo (e ce ne sono tanti tra quelli che accedono ai nostri sistemi di salute mentale) riuscisse a ingannare il mondo facendosi passare per sano mentre continua a sentire queste voci. Come riuscirebbe a trovare un compromesso tra queste voci che gli sgorgano dall’anima e il mondo che lo vuole, invece, equilibrato e razionale? Riuscirebbe, a un certo punto, a domarle o sarebbero le voci a domare lui? Oppure dovrebbe trovare una coesistenza complicata; quindi, mi sono divertito un po’ a immaginarla questa coesistenza; mi sono divertito a immaginare come un Michele Sabella, un ragazzino che sente le voci, possa non soltanto sopravvivere ma addirittura prosperare in un mondo che non riesce a vederlo fino in fondo. È stato un esperimento che tuttora mi è molto caro; il personaggio di Michele rimane un qualcosa a cui sono indissolubilmente legato, spesso mi manca. Anche per questo scrivere Ivan è stato molto difficile.
CP Ivan Castelli e Michele Sabella sembrano collegati da un filo rosso, nonostante le loro diversità. Entrambi sono uomini tormentati e irrisolti, che cercano di superare un trauma o colmare un vuoto interiore. Credi che personalità così complesse possano mai trovare una vera pace, o è proprio la loro impossibilità di risoluzione a renderli unici e, in senso letterario, “romantici”?
FS Senz’altro la seconda. Credo che i personaggi come Michele e Ivan non siano fatti per la pace o per la vita sedentaria; penso che la loro unicità di essere umano stia proprio in questo tormentarsi, in questo non accontentarsi della prima risposta, il voler guardare sul fondo, il che non è una cosa che li rende migliori o peggiori; rende semplicemente diversi. È un po’ un discorso di biodiversità, per giunta oggi molto affrontato e che va esteso anche alla “biodiversità delle anime”. Un mondo dove tutti funzionano come il procuratore Sonya Tagliaferri o come Martini, che sono persone validissime e che portano avanti una funzione sociale importantissima, diventa un mondo estremamente chiuso, un continuo autoreplicarsi. I Michele Sabella e gli Ivan Castelli hanno la funzione di scompaginare un po’ le carte, di andare “là dove nessuno è mai giunto prima” (citando Star Trek) e in questo ci aiutano, anche come società, ad ampliare i confini; del resto, abbiamo sempre un po’ bisogno di pionieri, no?
CP Per un autore che si occupa professionalmente di relazioni umane e dinamiche familiari, l’interazione tra i personaggi e la loro caratterizzazione sono elementi ancora più cruciali. Qual è il tuo approccio nel costruire conversazioni e linguaggio non verbale che ben descrivano le relazioni tra i tuoi personaggi? E come ti assicuri che questi scambi risultino autentici e al contempo siano in grado di rivelare gli aspetti psicologici per come li conosci tu?
FS Scrivere dialoghi è sicuramente molto difficile, però credo sia anche una delle cose più divertenti. Nel dialogo le relazioni prendono vita e le persone si mostrano per quello che sono senza bisogno di spiegarle dall’esterno. I romanzi che ho amato di più sono quelli in cui erano anche i dialoghi a farmi capire l’intimo di chi stava parlando. Inoltre, come dici tu, i dialoghi sono fatti anche di non verbale, cosa che spesso viene un po’ dimenticata. Io, per esempio, non sono un nemico giurato dei famosi dialogue tag che a volte servono anche al lettore per orientarsi. Un dialogo implica che non siamo fissi immobili muovendo soltanto la bocca, facciamo gesti, scarabocchiamo, ci passiamo la mano sulla testa, scrolliamo le spalle. Tutti questi gesti sono anche indicatori di un momento, di uno stato d’animo, di una di una relazione, di un’interazione che sta crescendo e credo sia bello poterli ritrarre e dare una visuale su questo aspetto del dialogo. Quando io scrivo un dialogo cerco sempre di avere presente chi sta parlando, anche in termini anche di caratteristiche demografiche, in base alle quali per esempio un adolescente parla in modo diverso da un professore di psicologia cinquantaquattrenne; è giusto che sia così, si rispettano alcune caratteristiche biografiche di base. Poi c’è l’unicità: per esempio Nadia è figlia di due genitori di cui uno è straniero; quindi, il suo rapporto con linguaggio è particolare. Inoltre, è figlia di un matrimonio molto conflittuale e freddo, ciò la porta a maturare determinate caratteristiche, per esempio sdrammatizzare, stemperare sempre il conflitto con una battuta. Ecco, io cerco di tenere a mente queste caratteristiche. Poi cerco di immaginare i personaggi nell’atto di parlarsi all’atto ipotizzando che gesto farei io. Tutto questo lavorare dietro le quinte porta, secondo me, a un dialogo positivo. Poi non ho la pretesa di giudicare il mio lavoro (sarebbe la cosa meno imparziale), me dai lettori mi arriva il feedback che i dialoghi di solito sono coinvolgenti, per cui evidentemente la cosa mi riesce abbastanza bene.
CP E adesso la “solita” ultima domanda, più attesa dai lettori (sicuramente più attesa da me): cosa bolle in pentola? E se bolle qualcosa, quanto manca alla “cottura” di questa novità?
FS Una parte di questo “bollire in pentola” è anche attesa, perché mi sono andato anche l’obiettivo di seguire questo libro che è appena uscito, di cercare di dargli visibilità e di curarne per bene l’uscita, meglio di come mi è capitato con altri romanzi. Quindi diciamo che, in questa fase, sono soprattutto concentrato sul riscontro di come Identità negate viene ricevuto.
Ciononostante, ci sono dei progetti tra cui uno non del tutto nuovo. Mi è stato proposto di ampliare Gancio largo (un romanzo breve), di provare a farne un romanzo un pochino più canonico da un punto di vista appunto della struttura narrativa, idea che mi diverte e che sto cercando di realizzare. Vedremo cosa ne uscirà. Poi ho una prima bozza di un possibile seguito di Identità negate che è nel cassetto in attesa di revisione; la storia è scritta però siamo in una fase primaria; quindi, ci vorrà tempo prima che abbia una forma “leggibile”.
Di idee ce ne sono; per esempio, mi piacerebbe mettere su carta una storia ambientata negli anni ’80, in particolare in quella estate pazzesca del 1982. Ero bambino e seguii la vicenda dell’Italia campione del mondo. C’è una parte di me che inizia a incuriosirsi in quell’estate che tutti ricordano come di festa, quasi irripetibile, ma chissà quante tragedie sono finite inascoltate proprio perché eravamo troppo impegnati a festeggiare. Ecco, in un contesto del genere, mi viene da metterci una storia brutta, qualcosa che stoni con quel clima di gioia.
CP Ringraziamo Ferdinando Salamino per essere stato con noi.